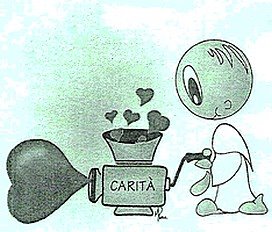“La Carità è una presenza. Bisogna non solo dare, ma darsi” (Raul Follereau)
Carità è un termine che deriva dal latino “caritas”, che significa affetto, benevolenza, con la derivazione da “carus”, che significa amato, caro e da “chàris”, cioè grazia.
La Carità è una delle virtù teologali per cui “amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi, per amore di Dio”; essa non ha come soggetto l’uomo, ma Dio. L’uomo è oggetto di Carità nella misura in cui Dio beneficia del suo amore chiedendo all’uomo di rispondere con la fede e la speranza.
Gesù dice: “Come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore” (Gv 15,9). “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni e gli altri, come io vi ho amati” (Gv 15,12).Gesù fa della Carità il comandamento nuovo; amando i suoi fratelli sino alla fine, egli manifesta l’amore che riceve del Padre. Amandosi gli uni gli altri, i discepoli imitano l’amore di Gesù, che essi ricevono a loro volta.
La Carità è un atto di amore, un gesto di affetto; la psicologia delle relazioni si occupa del dialogo tra due persone, della modalità di conversazione e di interazione tra più soggetti, la tipologia di scambio e di comunicazione, il linguaggio utilizzato, il comportamento adottato, le finalità, le intenzioni e i valori promossi.
Sappiamo infatti che la modalità di interazione dà origine alle diverse tipologie di relazione interpersonale, così succede che una persona può essere posta ad un livello inferiore o superiore rispetto all’altra, oppure si parla di relazione “sul piano dell’uguaglianza” quando nei modi di dialogare mettiamo in atto un comportamento in cui entrambe le parti ricevono, ma possono anche dare.
Il dialogo fra due persone suppone il reciproco ascolto, la conoscenza dell’altro e del suo problema o bisogno, la comprensione delle ragioni per le quali l’altro avanza delle richieste o esprime un bisogno, e la ricerca delle soluzioni per uscire dalla situazione del bisogno stesso.
Per noi cristiani al centro delle relazioni prende forma la Carità, proprio perché essa stessa è il cuore della vita cristiana e, in questa prospettiva, è possibile prendere in considerazione un dialogo nella Carità che, come tale, supponga un donare che non umilia ma che fa crescere.
Un dialogo che supponga un fare il bene senza scopi nascosti, senza creare delle inutili dipendenze o sentire il bisogno di legare la persona a noi stessi, perché tutto è contemplato nella libertà e gratuità.
Se dunque la Carità è il cuore della vita cristiana, delle nostre relazioni, del nostro agire, è possibile arrivare ad affermare che la stessa Carità è nella relazione e che la relazione è nella carità!
Quando stiamo in una relazione, sperimentiamo ogni volta la capacità di dare una forma alla relazione stessa, mediante il nostro agire, che è comportamento e che rispecchia il “nostro essere”.
Il fare influisce sul nostro essere, lo plasma secondo quello che fa, per cui se viviamo nella carità e facciamo la carità, essa stessa ci fa caritatevoli!
E’ nella relazione che noi cogliamo il bisogno dell’altro, ma prima ancora incontriamo la persona dell’altro.
Pensando alla Carità mi viene in mente la parabola del buon samaritano, in cui vengono usati verbi significativi quali: “vedere” il prossimo mentre si fa vicino per strada, “averne compassione”, “farsi vicino”, “fasciargli” le ferite, “caricarlo” sulla propria cavalcatura, “portarlo” all’albergo, “affidarlo” ad un altro, “essere pronti a” pagarne i servizi.
Questi verbi ci conducono ai tre stati d’animo del buon samaritano (che rappresenta ciascuno di noi), e che sono attraversati dal concetto della Carità:
“Rendersi conto della presenza altrui”, che vuol dire l’uscire dall’autoreferenzialità e dallo sguardo solo su se stessi;
“Sentire compassione”, che significa provare empatia, provare gli stessi sentimenti dell’altro;
“Fare quello che è possibile con i propri mezzi”, senza scaricare le proprie responsabilità, ma agendo mediante la capacità del “mettersi in gioco”.
La teologia ci insegna la Parola di Dio, trasmettendoci il messaggio che la Carità ha come frutti la gioia, la pace e la misericordia; essa esige la generosità e la correzione fraterna, è benevolenza, suscita la reciprocità, si dimostra sempre disinteressata e benefica, è amicizia e comunione.
San Paolo sosteneva: “Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità”.
La psicologia ci aiuta a comprendere il valore delle relazioni umane, il ruolo importante delle modalità di scambio, della comunicazione, del linguaggio, dell’empatia e della capacità di ascolto,
Follereau sosteneva che “la Carità è una presenza. Bisogna non solo dare ma darsi”; la Carità pulsa nella vita cristiana, impregnandosi nella figura del buon Samaritano che impara la dolcezza ispirandosi alla carità, regina delle virtù.
Stefi
(prossima pubblicazione sulla Voce di Seriate – Settembre ’16 – “Psicologia e Fede”)